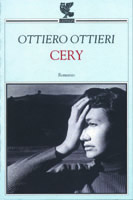L’IRREALTA’ QUOTIDIANA
di Geno Pampaloni
(«Il Resto del Carlino», il 9 luglio 1966)
Il libro di Ottiero Ottieri (L’irrealtà quotidiana, ed. Bompiani) è probabilmente la novità più rilevante
di questa fiacca stagione letteraria. E, comunque, è la definitiva conferma di uno scrittore acutamente
problematico, il libro che meglio ne esprime la natura complessa, la delicata sottigliezza intellettuale, e
la capacità di incarnare le ambiguità contemporanee con tutto il loro peso esistenziale e culturale. Non
tutte le tappe del lavoro di Ottieri, così ricco di divagazioni e di sperimentazioni, erano state sinora
convincenti: dal primo romanzo ancora post-ermetico (Memorie dell’incoscienza, 1954) al bel romanzo
di fabbrica (Tempi Stretti, 1957) alla diaristica tessuta di sociologia e stretta attorno ai nodi della
società industriale (Donnarumma all’assalto, 1959; La linea gotica, 1962), al racconto di registrazione
comportamentistica (L’impagliatore di sedie, 1964). E, in questi ultimi anni, sinceramente, avevo
creduto che Ottieri si stesse perdendo dietro le mode, che sprecasse il suo ingegno con un po’ di
leggerezza. Ma dopo questo libro devo riconoscere che ha avuto ragione lui, e che le linee del suo
lavoro hanno trovato un esito coerente, Ne L’irrealtà quotidiana, egli ha rifuso tutte le sue esperienze,
le ha radicalizzate, ne ha fatto una vicenda drammatica e reale, come dicono, “romanzesca”.
Vorrei qui notare come, dopo il Croce, le novità di genere letterario non siano mai grandi novità; e non
darei quindi troppo rilievo al fatto, da altri apprezzato, che si possa parlare, a proposito di questo libro,
l’architettura solida e fluente delle sue linee è una delle riprove più concrete della sua riuscita. Anche là
dove appaiono più tecniche, letterariamente più aride, queste pagine tengono sempre il passo, e il
lettore le accompagna. Il “romanzo” che c’è dentro funziona. Più interessante ancora mi sembra notare
che, sempre rimanendo nell’ambito dell’autobiografia, e cioè dell’esperienza diretta, Ottieri è riuscito a
ttrasformare il tema consueto della confessione nel tema dell’indagine. Da un capo all’altro del libro,
con tenacia umiltà e rigore, egli cerca veramente di dirci “chi è”.
Il protagonista del libro, il personaggio che dice “io “, è persona di conoscenza. La sua storia privata e
pubblica non si discosta troppo da quella di infiniti altri personaggi che hanno attraversato, nella nostra
letteratura, gli stessi tempi e le stesse avventure. Lo conosciamo alla perfezione; dall’infanzia difficile
al crollo dei valori nel corso della guerra, al soprassalto della Resistenza, alla rivolta contro i padri,
all’infatuazione socio-marxista, sino al nuovo ingranaggio, affascinante e repulsivo, dell’alienazione. Si
può dire che gran parte della nostra narrativa dell’ultimo ventennio non abbia fatto altro che
raccontarcene la storia. E poiché la fantasia di nessun poeta è riuscito a staccarlo da noi, a dargli un
nome preciso, è divenuto, codesto personaggio, folla un po’anonima, compagno di strada.
Ottieri non tenta neppure di definire poeticamente il suo personaggio, nebbioso e irrinunciabile come
tanti altri. Ma ci fa registrare sul suo conto alcune differenze importanti. Gli lascia, come a tutti i suoi
confratelli, la vocazione di confessarsi, ma porta la confessione fino in fondo, lo fruga con gli strumenti
più aggiornati di ricerca, e arriva al limite di una conoscenza senza indulgenze.
Le pagine iniziali del libro, nelle quali il personaggio è visto immerso Nel suo sentimento di irrealtà,
che gli acuisce la sensibilità e al tempo stesso gli toglie il gusto di vivere; o quelle finali sul “male”, che
egli vive in quanto è sul punto di smarrIrsi, di divenire un puro momento della sorte, lo specchio
disperato e convulso di una realtà nemica, sono tra le più originali del libro, e lasciarono un’emozione
profonda. Il giuoco dei sentimenti, la conoscenza, la stessa vita morale divengono per il personaggio di
Ottieri un itinerario scosceso e misterioso tra gli ineffabili, alle cui rive sciabordano paurose le
vibrazioni di quel “silenzio irrecuperabile” ove il male è presente con la sua selvaggia minaccia.
Inoltre Ottieri non dà al suo personaggio un vero e proprio ideale di vita, non gli affida un messaggio,
non lo piega verso un esito edificante. Il suo problema egli lo limita alla salvezza, alla “salute”
etimologica, che è un valore primario in sé, perché salvaguarda la sua cellula di umanità, unico
contributo possibile all’equilibrio del mondo. Egli gli dà non un ideale ma una cultura e una
metodologia (la compresenza indispensabile di Marx e Freud) e fa le parti molto giuste nel distribuire
la quota intellettuale e la quota intellettuale e la quota esistenziale del suo curriculum.
Per il resto, il suo compito non è esortativo ma diagnostico, ed egli insiste a fare il punto con accanita
precisione, a mettere a confronto il suo personaggio con le forze e le inibizioni che, dall’esterno o
dall’interno, lo condizionano. Il processo coincide con il libro, e non sono lasciati margini per altri
elementi di natura meno controllabile.
Ottieri ci parla, correttamente, delle diverse forme che assume oggi l’esigenza di mutazione dei rapporti
esistenti nella società, ma non dei possibili traguardi o modelli di tale esigenza; ci parla dell’impulso
all’utopia, non di un suo qualsiasi disegno. Questo dichiarato, lucido ed estremista soggettivismo crea
nel libro una dimensione onesta, e nel personaggio una gradevole novità. Rispetto ai suoi innumerevoli
confratelli letterari, questo protagonista di Ottieri è, finalmente, un dichiarato Narciso:individuato,
messo a fuoco; e naturalmente, sofferto. Nel libro di Ottieri ci sono parecchie cose opinabili, e alcune
anche che mi sentirei di respingere. Esso è fondato tutto sul presupposto che il marxismo sia stato
assorbito come una necessità nella nostra cultura, e che la psicoanalisi sia il più moderno strumento
d’analisi sull’uomo. L’arte sembra all’autore “indifesa di fronte alla distruzione
dell’autoconsapevolezza” e viva solo sul filo dell’azzardo della sua lotta con la ragione. Il “male” non è
più di natura morale, ma psichica. Si tratta, in questi casi ed in altri, di argomentazioni molto attuali ma
difficilmente verificabili; e c’è una certa facilità, nell’autore, a liquidare come “retorica” aspetti ancora
largamente problematici del sentimento contemporaneo. C’è detto in breve una certa indulgenza verso
lo snobismo. Tuttavia, alla fine del libro (e questa è un’altra conferma della sua creatività) il nostro
dissenso risulta marginale rispetto alla discussione che Ottieri permette di aprire.
Egli riesce a partecipare, nella sua ricchezza di ambivalenze, a specchio fedele di una cultura come la
nostra, priva di vere linee egemoniche, riesce a partecipare sia del tradizionale storicismo (pur
vivacemente aggiornato), sia delle aperture che l’avanguardia, e lo strutturalismo, offrono oggi al
pensiero estetico e critico. L’irrealtà quotidiana è un libro capace di instaurare un dialogo aperto verso
entrambe le direzioni. Il personaggio di Ottieri non è chiuso nella sua generazione, le sue
contraddizioni investono un arco più ampio nel quale due momenti del nostro tempo, oggi a contrasto,
si possono riconoscere, e in qualche modo incontrare. In sostanza, ci dice lo scrittore, il mondo muta
non soltanto nelle sue determinazioni storiche, ma anche, e forse soprattutto, nella soggettività
dell’uomo che le misura. Il rapporto dell’uomo contemporaneo con la complessa mistificazione del
mondo in cui vive, è un rapporto sempre di dare e avere eternamente ambivalente. La precisione con
cui tale rapporto va studiato e còlto è temperata dall’estrema labilità di ogni misurazione . Il relativismo
contemporaneo è la difesa più attuale contro i rischi dello scetticismo, oltre che contro quelli del
fideismo.
Questi dunque mi sembrano i due punti essenziali che raccomandano L’irrealtà quotidiana come un
libro innovatore: l’immagine che dà, concreta e non letteraria, del Narciso contemporaneo, spogliata di
molte sovrastrutture troppo idealistiche, e l’attualità di un’esperienza che coinvolge nei suoi interessi
due generazioni per molti versi oramai molto distanti l’una dall’altra.
Rimangono poi i meriti più squisitamente letterari di Ottieri. Solo un vero ingegno di scrittore poteva
riuscire nell’ardua prova di oggettivare i dati, estremamente soggettivi, di una fantasia che si misura
non nel proprio momento inventivo ma sull’infelicità e sulla malattia che usurano oggi la società e la
persona.
POCHE ROSE FRA LE SPINE DEL GRUPPO 63
di Andrea Zanzotto
(«La Stampa», 12 novembre 1983)
Intervento al convegno di Palermo su “Letteratura fra consumo e ricerca” dedicato ai vent’anni del
Gruppo 63.
“Soltanto dall’esterno si sarebbe potuto pensare a “un fatto nuovo” quando clamorosamente i giornali
cominciarono ad occuparsi del Gruppo 63 e dei suoi convegni. Come è noto in esso confluirono, in
modo più o meno convinto, molti che operavano già da anni, isolatamente o a piccoli gruppi, alla
ricerca di “fatti nuovi”, non solo in letteratura. E cioè facevano ricollegandosi ad esperienze analoghe
compiute in vari paesi. “Altri, forse più ossessionati dall’idea che nulla era veramente possibile, che si
era entrati nell’era della convenzionalità coatta, della reversibilità tra “autentico e falsetto”, e convinti
che l’isolamento dentro il “terrore di ogni giorno” (di cui doveva risolversi l’ideologia globale
dell’equilibrio del terrore), era il destino di questi decenni, non sentirono alcuna motivazione ad
inserirsi in “gruppi formalizzati”, preferendo un labile eppure assai resistente reticolo di rapporti
personali, semisilenziosi, ammiccanti, piuttosto “depressi”, lavorando tra infiniti dubbi e insieme, come
in stato di necessità, sotto la sferza, come se ne andasse della loro sopravvivenza fisica e quotidiana,
anche nello spostare una virgola.
Certi comportamenti del “Gruppo 63” e dintorni apparvero improntati a giovanile tracotanza, ad un
certo trionfalismo ingenuo, per quanto devoto ad un mito dell’astuzia e della massima autocoscienza
raziocinante, del “saperla più lunga degli altri”.
“Il lavoro teorico del Gruppo apparve comunque vivace, anche se non certo esplosivamente nuovo;
quanto alla bravura nella “fiction”, molti componenti ne avevano già dato prova e ne diedero conferma,
anche scomparsi i gruppi. La questione della conflittualità a proposito di un fantomatico potere
letterario è talmente irrilevante che non val la pena di soffermarcisi.”
“Oggi è ormai chiarissimo ciò che lo era assai meno decenni fa: e allora non si osava dirlo, non si osava
“saperlo”, si temeva di morirne ammettendolo. Oggi è scontato che tutto è immobile e glaciale pur
essendo in ebollizione e sanguinante entro il quadro della sovraccennata reversibilità tra convenzionale
e autentico. Ogni opzione, od optional letterario o culturale, viene ammessa in quanto post-moderna o
a.-moderna, para-moderna, iper o ipo-moderna e per ciò stesso modernissima. Tutto è ammonticchiato
e appiattito su un orizzonte carcerario a somiglianza della sagoma cartonacea, della corazzata felliniana
(nel film E la nave va), ma non per questo meno minaccioso, eppure tutto è sculettante e saliente entro
le prospettive di un teleschermo, come in una sfilata di moda adeguatamente sponsorizzata.
“Da tempo si è dentro quell’”al di là” in cui ortodossia ed eresia si riconoscono nell’identità di una
stessa persona, pur continuando a confliggere. E psichiatra e paziente si scambiano cortesemente i ruoli
in un liscio, che è tale anche quando prende le forme del più assatanato rock. Tutti si sentono sintomi e
ne campano in qualche modo.
“Il libro più violento, sacrificale, intimativo, evidenza e presenza di sintomo che sia apparso in questi
decenni è forse L’irrealtà quotidiana, scritto già nel 1966 da Ottieri, un isolato, un erratico. E doveva
proprio per il suo puzzo essere allontanato.
“Ma il libro sintomo per eccellenza, perché divenuto oserei dire per propria inerzialità, testo in quanto
“oggettalità semovente”, entro i tessuti socio-culturali che lo attendevano, e che esso ha rivelati, è
quello di Eco, Il nome della rosa è l’Ufo, il detector, il “non si sa bene che sintomo”, di cui non si può
saper bene “di che sia sintomo”, ma che lavora, lavora attraverso i continenti. E questo libro non viene
forse in qualche maniera dal Gruppo 63?”
OTTIERO ALL’ASSALTO
di Massimo Onofri
(«Diario della Settimana», 20-26 febbraio 2003)
[…] Mi fermo al 1966 quando viene pubblicato, appunto L’irrealtà quotidiana, di Ottiero Ottieri, tra
tutti questi anomali, forse il campione d’eccentricità: “saggio romanzesco”, come lo definiva il
risvolto di copertina dell’edizione Bompiani, e vincitore per la saggistica del Premio Viareggio dello
stesso anno, ma contro il parere di alcuni giurati che ne contestavano l’ascrizione al suddetto genere
letterario.
UN BUON RITORNO. L’irrealtà quotidiana, con una partecipata introduzione di Giovanni
Raboni, torna in libreria dal 26 febbraio per l’editore Guanda, impegnatissimo in questi ultimi anni
nella pubblicazione di tutte le opere di Ottieri: ed è evento, a un anno e mezzo dalla scomparsa dello
scrittore nato nel 1924, da non lasciarsi sfuggire. Ha ragione Raboni, quando individua a quest’altezza
un “autentico punto di non ritorno” nella storia di Ottieri: “Da quel momento in poi, voglio dire,
nessuno dei suoi libri – dai più apparentemente “narrativi” ai più apparentemente “teorici”, da quelli in
prosa a quelli in versi (quella sua prosa, quella sua versificazione rese diversamente ma in egual misura
inconfondibili da un’insaziabile motilità, da un’inquietudine ritmica e sintattica e microfigurale che non
conosce né concede requie) – sarebbe più stato classificabile dentro un unico genere, tutti avrebbero
condiviso (ciascuno, si intende, a suo modo, con una sua diversa coloritura, o meglio, una sua svolta,
un suo scarto timbrico e tonale) la sorte non meno inebriante che rischiosa d’una doppia o tripla o
multipla appartenenza: racconto, trattato, diario, confessione, pamphlet….-fino, in prospettiva, a un
vero e proprio sgretolamento, a una vera e propria dissoluzione, non programmatica, certo, ma proprio
per questo così effettiva e radicale, di qualsiasi vecchia e finanche, perché no?novissima convenzione
formale”.
E dire che solo tre anni prima Ottiero aveva congedato La linea gotica, che, lavorato su una materia
analoga a quella del già celebrato Donnarumma all’assalto (1959), aveva costituito l’oggetto di
un’appassionata discussione sui rapporti tra letteratura e industria, quelli che molto avevano interessato
il Vittorini e il Calvino del Menabò.
Non solo:il decennio s’era pure aperto nel nome di Alberto Moravia, autore di un romanzo come La
noia (1960) che aveva provocato, quanto a temi come alienazione e depersonalizzazione, un animoso
dibattito. Quel Moravia che nell’ Irrealtà quotidiana, proprio Ottieri convoca tra i suoi interlocutori
privilegiati: insieme al Sartre di L’essere e il nulla (1943). Intendo dire con questo che c’erano tutte le
premesse perché il libro di Ottieri fosse troppo sbrigativamente rubricato, come in parte avvenne,
sull’agenda di quel freudo-marxismo che aveva trovato, o stava per trovare, un successo facile e
popolare nei libri del più commerciale e commercializzabile dei francofortesi, il Marcuse di Eros e
civiltà (1955) e ancor più, di L’uomo a una dimensione (1964).
Non voglio certo sostenere qui che Ottieri non abbia operato sotto il cielo della nobilissima
costellazione novecentesca che ha avuto come sue stelle fisse Marx e Freud: basterebbe pensare solo a
quanto l’abbia occupato, proprio nell’Irrealtà quotidiana, un concetto come quello dell’Entfremdung,
nel parossistico tentativo di trovare un punto di congiunzione tra le alienazione psicologica e quella
sociologica, fatta salva l’intercapedine, tra l’una e l’altra, entro cui si va a collocare proprio il
sentimento d’irrealtà. Né vorrei sottrarre la sua opera alla più generale (e generica) temperie che, in
quegli anni, s’agitava, tra sentimento dell’assurdo e denuncia dell’incomunicabilità, a diagnosticare il
terminale, se non agonico, approdo del personaggio –uomo: perché vi si colloca, questa sua opera, con
esiti tra i più originali.
IL MONDO CHE CAMBIA. Il fatto è però, che L’irrealtà quotidiana è molto altro: per un
discorso serrato che vuole avvalersi, immediatamente, dei più aggiornati risultati delle nuove scienze
sociali. Innanzitutto, una specie di riflessione trascendentale sull’io (corporeo, psichico, culturale,
sociale), che funzioni però, come una peculiarissima camera iperbarica in cui ogni singolo atto
percettivo sia sottoposto a spasmi. Il libro, in effetti, sin dalla prima riga, si congeda da una nozione
meramente cartesiana del pensiero e pare come anticipare, nella rivendicazione della radicale
ambivalenza della mente, nell’individuazione a livello tanto inconscio che conscio d’una vera e propria
bi-logica, certe avventurose e suggestive posizioni di Ignacio Matte Blanco : Il meccanismo (ossessivo)
di questo vecchio dramma della scelta è semplice: appena si decide una via, si finisce anche per
decidere la via opposta. Appena si tocca una cosa o certezza, si rimbalza, per ciò stesso, su un’altra
cosa o certezza che si trova o inventa. Non si è dubbiosi metodicamente ma disperatamente e quindi
non vale la famosa certezza del dubbio; si è dubbiosi in quanto accanitamente ambivalenti e si è
ambivalenti anche verso la propria ambivalenza, Si vogliono due cose sempre ma come volendone una
sola.”
Ecco “Cogito ergo sum”, ma anche (sed etiam) “ergo non sum”. E c’è di più: se è vero che la dialettica
estenuata, estenuante, delle proposizioni (sempre definitorie e mai definitive) delle contraddizioni,
tende a saturare il discorso, mirando utopicamente (distopicamente?) a far coincidere la mente col
cervello. Laddove il termine di saturazione sta semplicemente qui, come ha brillantemente intuito
Raboni, per quello di somatizzazione. Perché questo è stato il tentativo di Ottieri: rapportarsi alla lingua
come se la lingua potesse sovrapporsi al linguaggio del corpo, potesse valere per quel linguaggio, fino a
coincidere con esso. Sta proprio qui, secondo me, al ragione per cui le prove della Neoavanguardia (i
cui adepti sono comunque da contare tra gli interlocutori principali di questo Ottieri) non poterono non
risultargli ludiche, sottratte come sono al dramma gnoseologico ed esistenziale, e consegnate a una
dimensione sostanzialmente formalistica: soprattutto quando “dietro una neo-utopia linguistica”, la
Neoavanguardia rischiava di contrabbandare “una vecchia ansia tanto perfezionistica nel cercare
definizioni del sentimento d’irrealtà, quanto vile nell’affrontare il mondo intimo.” Con Ottieri, occorre
sottolinearlo, siamo subito dentro una regione di perplessa e tormentata filosofia, mai annebbiata dal
volontarismo dell’ideologia, da una tirannia del progetto che potesse fare aggio (come spesso ha fatto
nel Novecento più autistico) sul corpo vivo dell’opera, sulle sue costitutive libertà. Sulla sua più
autentica vocazione autolegislativa: non per niente, l’accanita interrogazione del sentimento d’irrealtà
diventa qui anche una meditazione sul non-essere, sul nulla, sul suicidio, sulla morte. In tal senso, lo
stupefacente e non lontano De morte (1997) affonda senz’altro le sue radici – non solo quanto a temi,
ma anche per la forma in cui è stato concepito – nell’Irrealtà quotidiana.
IL TOTALITARISMO DELL’EGO. Se fossi costretto, però, a indicare uno dei possibili centri di un
libro così poco centrato, non avrei esitazioni: e indicherei il capitolo della quarta pare (Il male)
intitolato L’io e l’io dal 1940 a oggi. Non è difficile ricavarne il capo d’un filo che riannoda L’irrealtà
quotidiana al libro d’esordio di Ottieri, Memorie dell’incoscienza (1954), illuminandolo nella sua più
vera luce egolatrica: mentre lo prolunga verso altri due libri inquietanti, anomali e gravidi d’un tempo
che oltrepassa di molto quello in cui sono stati generati, quali sono Il pensiero perverso (1971) e Il
campo di concentrazione (1972). Tutti insieme, questi libri, aprono un discorso decisivo e per niente
concluso su un altro totalitarismo doloroso del secolo appena trascorso: il totalitarismo dell’Io. Non è
stata, questa feroce tirannia della soggettività, uno dei tratti salienti di quel processo della distruzione
della ragione che Lukàcs voleva ravvisare,già operante, nel razionalismo di Bacone e Galileo fino a
culminare nei campi di sterminio hitleriani? Salvo poi, Lukàcs, cercare salvezza in un altro Leviatano,
ben più pericoloso credo della ratio scientifica: quella ragione dialettica, di matrice hegeliana, cui si
potrebbero imputare, non senza ragione, altri gulag. Ma, anche in questo caso, Ottieri s’è guardato bene dall’assecondare qualsiasi ipotesi di sorti magnifiche e progressive. E contro la tirannia di quella specie
di Re Sole che è stato l’ego novecentesco, ha giocato la sua solitaria carta di regicida, di riottoso e
ostinato monarcòmaco.